La data di nascita è ignota, l’ascendenza genealogica non del tutto sicura e di recente sottoposta a nuova indagine da A. Tilatti, che ha scartato la precedente attribuzione di Bellino alla famiglia dei Bertaldi, individuandone il padre in un non altrimenti identificato Audo. Prete almeno dal 1107, anno della sua prima menzione, Bellino è il primo tra i canonici destinatari di una donazione al capitolo della cattedrale di Padova nel 1108 e l’anno successivo riveste la carica di arciprete della stessa cattedrale. Fin dalla sua prima apparizione figura al fianco di Sinibaldo, il vescovo di orientamento filopapale contrapposto al candidato di obbedienza imperiale e costretto dalla violenza regia, cioè di Enrico V, ad abbandonare la sua sede.
Bellino seguì con tutta probabilità Sinibaldo nel suo esilio, ma nel 1115 risulta nuovamente a Padova, in una fase di componimento delle divisioni. Superato definitivamente lo scisma e ritornato Sinibaldo in sede, Bellino operò al vertice del capitolo cattedrale per essere poi eletto vescovo fra il 1126 e il 1128. La sua attività si svolse in continuità con quella del suo predecessore: Bellino confermò e in parte ampliò le concessioni di Sinibaldo al monastero veneziano di S. Cipriano, dipendente dall’abbazia di Polirone; si adoperò a favore di S. Croce di Campese, monastero assoggettato nel 1127 alla stessa abbazia di Polirone, alla quale nel 1124 Sinibaldo aveva sottoposto il monastero di Praglia; mantenne infine il legame affettuoso con la chiesa di S. Maria delle Carceri, che durante l’episcopato di Sinibaldo aveva adottato la vita comune e le istituzioni di S. Maria di Porto di Ravenna: Bellino beneficò la canonica, la sostenne presso il pontefice, invocandone la protezione, e come Sinibaldo fu annoverato tra i benefattori nel necrologio del monastero, ricordato quindi nelle preghiere della comunità.
I singoli interventi citati s’inserivano in un più ampio progetto di riordino della diocesi padovana sotto l’aspetto sia patrimoniale sia giurisdizionale, dopo le lotte e i disordini dei decenni precedenti. Alla povertà denunciata nel 1130 da Bellino («i beni del mio episcopato sono stati dilapidati per i contrasti fra Regnum e Sacerdotium») faceva eco Innocenzo II nel 1132, che si preoccupava di confermare al vescovo padovano tutte le chiese usurpate da laici e da monaci durante l’episcopato suo e del suo predecessore. Anche se non risulta un’opera parallela nei confronti dei monasteri, un preciso impegno di recupero di chiese e di porzioni di chiese private dalle mani di laici, in consonanza con i ripetuti canoni conciliari contemporanei, è attestato nel 1134 (diritti della famiglia da Montagnone sul monastero di S. Daniele), nel 1138 (cappella di Montegalda refutata dai nobili da Baone), nel 1146 (diritti dei signori da Caldonazzo sulla chiesa di Curtarolo). Tale azione si collegò alle vigili cure circa la tenuta delle strutture diocesane: gli atti di donazione previdero clausole a difesa sia dei diritti delle chiese parrocchiali sia dei diritti vescovili circa la consacrazione dei chierici e dell’olio santo, la presenza ai sinodi e la giustizia ecclesiastica. In data incerta Bellino intervenne in favore dei sacerdoti delle cappelle cittadine concedendo loro il quartese della città e del territorio, intervento che conforterebbe l’ipotesi secondo cui Bellino in qualche modo sostenne la nascita della «congregazione dei sacerdoti e dei chierici di Padova», l’associazione che riuniva il clero officiante le cappelle urbane, incaricato di nuovi compiti di cura d’anime.
Il favore per le istituzioni canonicali, la promozione di monasteri, canoniche e chiese, la vigilanza sulla stabilità delle gerarchie d’ufficio e di giurisdizione compongono l’immagine di un vescovo aperto alle nuove esperienze religiose, impegnato nell’attento governo della sua chiesa, interessato, anche a seguito delle vicende dello scisma, al corretto e disciplinato svolgimento della vita ecclesiastica: nella documentazione che lo riguarda, si parla di successori catholici, di funzioni parrocchiali da esercitare «secondo i canoni», di un’obbedienza, da parte dei suoi canonici, ecclesiastica e fidelis. Un vescovo ormai in stabile colloquio con la Sede apostolica e consapevole del ruolo di guida da essa assunto ed esercitato all’interno della cristianità, ad esempio attraverso la convocazione di sinodi generali, la cui eventualità era da Bellino esplicitamente contemplata. Non va però dimenticato il significato che l’episcopato di Bellino rivestì nella storia civile padovana: se, durante lo scisma, la compresenza e il contrasto fra due vescovi aveva visto emergere partiti che esprimevano orientamenti di politica soprattutto locale, con gli episcopati di Sinibaldo e di Bellino il dialogo con la società urbana e con le forze signorili del territorio si mantenne intenso, anche per la presenza giurisdizionale e patrimoniale che l’episcopato, seppur indebolito, conservava.
Bellino morì quasi certamente a Padova il 26 novembre del 1147, data ricostruibile attraverso il necrologio di S. Maria delle Carceri e dati documentari indiretti. Posteriore di più di un secolo è la vita di un san Bellino vescovo e martire attribuita al domenicano Bonagiunta, vescovo di Adria (12881304). Le vicende che portarono alla venerazione di un san Bellino nella diocesi di Adria non sono del tutto chiarite. Dall’esame condotto da A. Tilatti, le lezioni relative alla festa del santo risultano una mescolanza di elementi riconducibili a personaggi storici diversi e ricomposti in un disegno che rispecchia gli intenti dell’agiografo più che la realtà storica di Bellino. Secondo il testo agiografico, Bellino, già vescovo di una diocesi tedesca, fu nominato vescovo di Padova dal pontefice, preoccupato di sanare uno scisma apertosi nella sede vescovile a causa di indebite pressioni politiche. Zelatore e difensore delle libertà della sua chiesa, Bellino cadde ucciso nel ritorno da Roma, ove s’era recato per ottenere protezione e consiglio, nei pressi della chiesa di S. Giacomo di Fratta (in diocesi adriese). Sul luogo fiorirono subito i miracoli ma poi, in seguito a un’alluvione e al crollo della chiesa, il corpo santo fu sepolto dal fango e cadde nell’oblio. L’ invendo fu opera di un uomo pio che, guidato da un sogno, giunse sul luogo recuperando l’arca marmorea, la quale, posta su di un carro, fu prodigiosamente guidata alla pieve di S. Martino di Variano da cui S. Giacomo dipendeva.
Il testo attribuito a Bonagiunta, ripreso anche nel lezionario della cattedrale di Padova, razionalizza un culto che, pur non avendo quasi nulla a che vedere con il Bellino storico (cui furono certamente estranei l’assassinio e il martirio), si mantenne e anzi si potenziò allorché, nel 1489, Bellino fu elevato a patrono della diocesi di Adria, diocesi che con quella di Padova vide la diffusione del culto. Il modello proposto dal testo tardoduecentesco era quello del martire per la libertas Ecclesiae e per l’obbedienza alla Chiesa di Roma, modello funzionale all’azione che, come vescovo, Bonagiunta andava conducendo nella diocesi, e probabilmente ispirato da una «ben determinata congiuntura storicopolitica: la predominanza padovana nel Polesine» (di qui l’adozione e la proposta di un santo padovano le cui vicende avevano fortissime analogie con quelle del contemporaneo vescovo padovano, Bernardo). Nella devozione popolare la venerazione per Bellino si legò al suo potere taumaturgico nei casi di rabbia canina, una virtus già celebrata, secondo il testo agiografico, dal vescovo adriese Rolando ai primi del Duecento e invocata a lungo nei secoli, come risulta dai registri parrocchiali (all’a. 1727), da ex voto e da stampe popolari di fine Ottocento. La chiesa di S. Martino di Variano, che poi insieme con la località mutò il suo titolo in S. Bellino, fu precoce meta di pellegrinaggio, come confermano la recente ricognizione del contenuto dell’arca e le monete in essa rinvenute.
Storia del ritrovamento del corpo di San Bellino
:
Il Paese di San Bellino prende il suo importante no
me del religioso Bellino, il quale era di
nazionalità tedesca e nacque nell’anno 1090 nel Duc
ato di Mekelembock.
Cresciuto seguendo le virtù cristiane e morali, dur
ante la sua maturità si è reso noto per la sua
grande abilità nel condurre nella giusta strada le
anime degli uomini e proprio per questo fu
promosso alla carica di vescovo. La prima carta che
lo registra con il titolo vescovile risale al 6
dicembre 1128.
Al suo tempo, circa l’anno 1144, vigeva l’obbligo d
ei vescovi, dopo la loro promozione, di recarsi a
Roma dal vicario di Cristo Celestino o Lucio, anni
in cui il Clero di Padova dopo la morte del suo
Vescovo Sinibaldo, era discorde nell’elezione del s
uo successore.
Nel momento in cui Bellino sostenne l’udienza con i
l Papa quest’ultimo, venendo a conoscenza
delle virtù e dei meriti del Santo Uomo, dispose ch
e il vescovo non dovesse ritornare in Germania
ma lo trasferì nella diocesi padovana in Italia, co
n il comando di andare a indirizzare il clero e
popolo e di sedare a nome del Papa tutte quelle tur
bolenze che si erano venute a manifestare nella
città.
Nella diocesi padovana erano numerose le famiglie c
he ingiustamente possedevano dei beni
destinati alla proprietà della Chiesa, di questi al
cuni Bellino ne recuperò per affidarli alla mensa d
ei
poveri di Cristo, al Priore della canonica di Santa
Maria delle Grazie per farne un alloggio per i
poveri ed infine un’ ultima parte venne riservata a
lle Chiese. Alcuni nobili Padovani della famiglia
Capovacca occupavano alcuni terreni della Chiesa di
Bellino e chiaramente quest’ultimo voleva che
gli fosse restituito quello che di diritto gli spet
tava per poterlo affidare alla propria comunità di
fedeli. Fu per questi dissidi che Bellino fu assas
sinato proprio da sicari di quella stessa famiglia
sopra menzionata.
La storia che ci è stata tramandata racconta che Be
llino Vescovo, di ritorno dalla diocesi di Ferrara
e passando per la Via Vespara dell’attuale San Bell
ino, fu aggredito da dei spietati avversari che gli
tesero un agguato. Il Santo Uomo fu fatto fermare e
scaraventato a terra dal suo cavallo ad opera dei
loro molesti cani che rabbiosamente lo assalirono.
I sicari lo lasciarono sulla strada pubblica
trucidato da colpi di pugnale e successivamente gli
abitanti dell’attuale Fratta Polesine, udito il
pericolo, si recarono sul luogo del misfatto e onor
evolmente levarono da terra il santo corpo ormai
senza vita e lo seppellirono in una chiesa chiamata
S. Giacopo, collocandolo in un’arca di marmo
che si trovava nella suddetta Chiesa.
Bellino iniziò a compiere un infinito numero di mir
acoli nei confronti delle persone che
accorrevano a visitare l’Illustrissimo Corpo, e pro
prio per questo il Santo Pontefice Eugenio III,
mosso dalla quantità dei prodigi che erano avvenuti
in nome di Bellino, lo dichiarò Martire del
Signore dandogli quella venerazione e quel culto ch
e meritava una persona che, per il bene della
Chiesa e per la difesa del patrimonio dei poveri di
Cristo, aveva perso la propria vita.
Più tardi successe che il Po’ ruppe i suoi argini i
n località Ficarolo e l’acqua si diramò nelle
campagne e nelle valli comprese anche tra Fratta e
Rovigo allagando qualsiasi territorio.
Per quest’imponente alluvione ne restò vittima anch
e la chiesa di San Giacomo, situata nelle
vicinanze di Fratta, e l’arca che conteneva il prez
ioso tesoro del corpo del Santo Vescovo e Martire
Bellino fu letteralmente sommersa dalla sabbia e da
i detriti che l’acqua del Po’ si portava addietro,
sicché si era smarrito il luogo della sepoltura del
Santo Uomo.
Trascorsi circa 137 anni, dopo che le rotte del Po’
si erano momentaneamente estinte e che la
fisionomia del grande fiume aveva assunto un altro
corso, il quale si propendeva maggiormente
verso il mare, accadde che alcuni paesani di San Ma
rtino di Variano, antico nome dell’attuale San
Bellino, cominciarono a bonificare quei terreni pal
udosi per aver così modo di coltivare degli
appezzamenti di terreno.
Un certo Giovanni Dalla Fratta, a cui toccò la sort
e di lavorare nel terreno dove un tempo sorgeva la
Chiesa di San Giacomo, venne informato che il terre
no che lui stesso coltivava nel sottosuolo
conteneva le sacre spoglie di Bellino Vescovo. Così
Giovanni, con l’aiuto dei suoi figli, volle
verificare quest’informazione che gli era stata per
venuta e decise di iniziare a scavare in prossimità
del terreno che gli era stato indicato. Essi, dopo
aver scavato a lungo, trovarono effettivamente
l’arca contenente le Sacre Spoglie, e provarono a s
ollevarla dal terreno con l’aiuto dei suoi
numerosi buoi, con l’obiettivo di portarla a Fratta
per renderla celebre e illustre per il tesoro che
essa potenzialmente doveva custodire; ma si sa che
non sempre le divine volontà equivalgono a
quelle degli uomini. Ma purtroppo nemmeno tant
a forza messa insieme servì a sollevare
l’imponente arca marmorea. Fu così che successivame
nte Giovanni venne inspirato ad aggiungere
al poderoso numero di buoi due esili mucche che ave
vano da poco partorito, ed esse, messe a capo
del corteo, riuscirono a sollevare l’arca e si dire
ssero così verso l’antica chiesa rurale di San
Martino di Variano, anziché verso la Chiesa di San
Pietro e Paolo di Fratta Polesine.
Arrivate alla porta di questa chiesa le mucche si f
ermarono immobili e nemmeno riuscirono a
proseguire oltre. Sopraggiunto il contadino Giovann
i, che proseguiva il suo cammino a passo lento,
esso piantò atterra la sua verga di pero che gettò
da subito le radici e si protese verso l’alto per
germogliare con foglie in un fioritissimo albero di
pero, il che fece in modo di far conoscere ancor
più maggiormente la volontà di Dio. Fu così che ine
vitabilmente le spoglie di San Bellino furono
collocate nella Chiesa di San Martino di Variano, a
ccolte dalla grande allegria e gratificazione nei
confronti del Martire che gli abitanti del Paese ma
nifestarono.
Proseguirono ancora i miracoli che Bellino faceva m
anifestare nei confronti dei suoi devoti uomini,
sia che si trattasse di infortuni e sia che si trat
tasse di malattie. Ma il Santo Uomo si mise in
evidenza nella capacità di curare la rabbia, quasi
volesse far palese che, chi da cani rabbiosi fu
assalito e gettato a terra perdendo la vita, fosse
diventato sanatore di questo male.
In più si racconta che anche la chiave arroventata
della chiesa che porta il suo nome aveva la stessa
virtù di preservare gli animali dalla rabbia, tanto
che sparse per tutt’Italia dovrebbero esserci altr
e
chiavi simili con le stesse proprietà in devozione
a questo prodigioso Santo.
I cittadini di Rovigo successivamente pretesero si
levare il corpo del Santo dalla chiesa di San
Martino per destinarlo nella loro Chiesa principale
, dopo che il Vescovo di Adria del tempo aveva
espressamente scritto le ragioni per cui fosse gius
to trasportarlo nella città, dove sarebbero potutit
i
accorrere un maggior numero di fedeli e dove si pen
sava che il corpo avrebbe potuto godere di
maggiori privilegi. Al ché replicò il Cavagliere Gi
ovan Battista Guarini, nobile ferrarese che
possedeva a San Martino numerosi beni e ribadì che
il corpo doveva restare dove l’aveva voluto il
Cavaliere e la nobile Giulia Ariosti Guarini che, a
ttraverso le sue cospicue offerte, permise di
decorare la cappella maggiore di San Bellino nell’a
nno 1647 dopo che nel 1640, e precisamente il
25 novembre, in essa erano state trasportate le spo
glie del santo martire ad opera del Vescovo di
Adria Polo Savio, e collocate in una tomba di marmo
alzata su quattro pilastri.
Infine, nel 1774, il Papa Clemente XIII elevò a Bas
ilica la Chiesa di San Bellino il quale stabilì che
il 26 Novembre sarebbe stato festeggiato il Santo P
atrono del Paese, in coincidenza dello stesso
giorno dell’anniversario della sua morte.
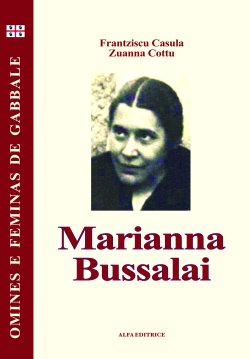

 Eppure, a partire da quell’anno cruciale, nei secondi anni Cinquanta e poi ancora negli anni Sessanta, nel Pci fu aspra burrasca, duro confronto di idee. (…). In quella dura verifica nemmeno Togliatti, con la sua straordinaria autorità, passò del tutto indenne. C’erano già state le burrasche della primavera del 1956, il tempestoso Consiglio nazionale dell’aprile, il Comitato centrale di luglio. Parve per un momento che l’VIII Congresso avesse ricomposto un’unità, se non riportato la calma. Ma non era vero. Lo scontro esplose duramente, come non avevo visto mai, al Comitato centrale che si tenne dopo il XXII Congresso del PCUS nel 1961. Chruščëv, insieme con l’esaltazione dei successi della sua politica economica, aveva riproposto dalla tribuna del congresso i temi dell’attacco demolitore a Stalin, accompagnandoli con due proposte clamorose: la rimozione della salma di Stalin dal Mausoleo della Piazza Rossa e il cambiamento del nome della città di Stalingrado in Volgograd. Al rientro da quel congresso, in un incontro che ebbi con lui per riferirgli di questioni parlamentari italiane (allora ero vicepresidente del gruppo comunista della Camera) trovai Togliatti di pessimo umore, e mi parlò di Chruščëv con accenti di aperto fastidio, per non dire sarcasmo: la cosa non mi sorprese, ma questa volta c’era una irritazione che non si celava. Come ho detto, quelle due figure non si amarono mai: forse, se pure ci fu un momento di interlocuzione fra loro, non si capirono mai.
Eppure, a partire da quell’anno cruciale, nei secondi anni Cinquanta e poi ancora negli anni Sessanta, nel Pci fu aspra burrasca, duro confronto di idee. (…). In quella dura verifica nemmeno Togliatti, con la sua straordinaria autorità, passò del tutto indenne. C’erano già state le burrasche della primavera del 1956, il tempestoso Consiglio nazionale dell’aprile, il Comitato centrale di luglio. Parve per un momento che l’VIII Congresso avesse ricomposto un’unità, se non riportato la calma. Ma non era vero. Lo scontro esplose duramente, come non avevo visto mai, al Comitato centrale che si tenne dopo il XXII Congresso del PCUS nel 1961. Chruščëv, insieme con l’esaltazione dei successi della sua politica economica, aveva riproposto dalla tribuna del congresso i temi dell’attacco demolitore a Stalin, accompagnandoli con due proposte clamorose: la rimozione della salma di Stalin dal Mausoleo della Piazza Rossa e il cambiamento del nome della città di Stalingrado in Volgograd. Al rientro da quel congresso, in un incontro che ebbi con lui per riferirgli di questioni parlamentari italiane (allora ero vicepresidente del gruppo comunista della Camera) trovai Togliatti di pessimo umore, e mi parlò di Chruščëv con accenti di aperto fastidio, per non dire sarcasmo: la cosa non mi sorprese, ma questa volta c’era una irritazione che non si celava. Come ho detto, quelle due figure non si amarono mai: forse, se pure ci fu un momento di interlocuzione fra loro, non si capirono mai. Togliatti intese tutto come un attacco ingiusto e sbagliato, e anche un perdere la testa. Fece una replica durissima, la cui sostanza era quasi letteralmente questa: volete cambiarmi? Provateci. Ce la vedremo nel Partito. E io rivendico la mia libertà di fare una lotta di frazione (fu questa la parola inedita e chiarissima che usò). Ma – prudente come sempre era, anche nelle sue collere più furibonde – disse che non avrebbe pubblicato la sua replica. E tenne duro fino all’ultimo. La discussione tornò nella riunione della Direzione del 17 novembre, dove tutti, senza ritirarsi, ammorbidirono però la tensione, senza spostamenti sostanziali di posizione, ma orientati ad evitare la frattura delicatissima con il grande leader. Il documento conclusivo, affidato a Paolo Bufalini e a Enrico Berlinguer, cancellava l’urto, ma, senza dubbio, segnava un passo avanti nella critica dei comunisti italiani non solo a Stalin, ma al sistema sovietico. Continuava la tattica, così cara al comunismo italiano, della differenza senza conflitto, che a lungo ci illuse.
Togliatti intese tutto come un attacco ingiusto e sbagliato, e anche un perdere la testa. Fece una replica durissima, la cui sostanza era quasi letteralmente questa: volete cambiarmi? Provateci. Ce la vedremo nel Partito. E io rivendico la mia libertà di fare una lotta di frazione (fu questa la parola inedita e chiarissima che usò). Ma – prudente come sempre era, anche nelle sue collere più furibonde – disse che non avrebbe pubblicato la sua replica. E tenne duro fino all’ultimo. La discussione tornò nella riunione della Direzione del 17 novembre, dove tutti, senza ritirarsi, ammorbidirono però la tensione, senza spostamenti sostanziali di posizione, ma orientati ad evitare la frattura delicatissima con il grande leader. Il documento conclusivo, affidato a Paolo Bufalini e a Enrico Berlinguer, cancellava l’urto, ma, senza dubbio, segnava un passo avanti nella critica dei comunisti italiani non solo a Stalin, ma al sistema sovietico. Continuava la tattica, così cara al comunismo italiano, della differenza senza conflitto, che a lungo ci illuse. L’altra lettura, ribadita rigidamente da Amendola e da Emilio Sereni, poneva al centro l’arretratezza del capitalismo italiano anchilosato dalla sua rigida e angusta struttura monopolistica. Ne sgorgava – per ambedue – il grande compito ‘progressivo’ del movimento operaio di trarre il Paese da quello storico ritardo nello sviluppo. Da ciò l’aspro scontro con Lucio Magri che evocava invece la lotta all’«opulentismo» del capitalismo maturo, con Rodolfo Banfi che contestava le vecchie letture della questione meridionale e con Vittorio Foa che sollecitava l’impegno contro le nuove forme dell’alienazione del lavoro e, soprattutto, concentrava lo sguardo sui conflitti che si aprivano nelle cittadelle industriali e sui compiti inediti a cui veniva chiamato il soggetto sindacale.
L’altra lettura, ribadita rigidamente da Amendola e da Emilio Sereni, poneva al centro l’arretratezza del capitalismo italiano anchilosato dalla sua rigida e angusta struttura monopolistica. Ne sgorgava – per ambedue – il grande compito ‘progressivo’ del movimento operaio di trarre il Paese da quello storico ritardo nello sviluppo. Da ciò l’aspro scontro con Lucio Magri che evocava invece la lotta all’«opulentismo» del capitalismo maturo, con Rodolfo Banfi che contestava le vecchie letture della questione meridionale e con Vittorio Foa che sollecitava l’impegno contro le nuove forme dell’alienazione del lavoro e, soprattutto, concentrava lo sguardo sui conflitti che si aprivano nelle cittadelle industriali e sui compiti inediti a cui veniva chiamato il soggetto sindacale. La sconfitta dell’XI congresso
La sconfitta dell’XI congresso Ma, nel grosso corpo del PCI, nonostante le parole in corso in certi casi e in certi luoghi, la questione stessa, si potrebbe dire l’ipotesi – per eventuale e dubbia che fosse – di una transizione al socialismo morì o, più esattamente, si dileguò allora, si spense senza dichiararsi, sino alla sepoltura ufficiale della Bolognina. Restò sul campo, stranamente, la parola «socialismo», sulla bocca – che so? – di Enrico Boselli o, a volte, di Giuliano Amato, o (mi pare) a strappi anche su quella di Massimo D’Alema. Ma è chiaramente un residuato bellico, un fronzolo. Sicuramente allude ad altro. Ammesso che alluda. In fondo si rompeva, o si scioglieva, quell’ambiguità che aveva sospinto Togliatti a parlare del Partito comunista italiano come di una «giraffa». Il comunismo italiano, nonostante le nefandezze e le colpe che gli hanno imputato via via i suoi avversari, si recinge e riassume nel compito di sostenere l’evoluzione democratica di un capitalismo segnato da passioni e rigurgiti autoritari, da violenze antiche e moderne e da lunghe angustie e salti improvvisi. Giunto, in sostanza, a questa scelta e autolimitazione, alla metà degli anni Sessanta, è chiaro che il PCI subirà il Sessantotto, anche se fornirà ad esso – è stupido dimenticarlo – quadri, truppe, passioni. E fecondità di ricerche, capacità di scoperte. E quando l’onda sessantottina e l’«autunno caldo» si frangeranno e rifluiranno, il PCI apparirà ancora come speranza di cambiamento prima di tutto a un’onda di giovanissimi che avanzavano sulla scena, quasi scavalcando i sessantottini, e alle masse femminili che venivano proclamando la loro alterità. Apparirà come la forza politica in campo che può mettere in discussione in Italia l’eterna preminenza della Democrazia cristiana. Moro stesso parlerà della forza comunista (il nome è ancora quello) come una possibile alternanza.
Ma, nel grosso corpo del PCI, nonostante le parole in corso in certi casi e in certi luoghi, la questione stessa, si potrebbe dire l’ipotesi – per eventuale e dubbia che fosse – di una transizione al socialismo morì o, più esattamente, si dileguò allora, si spense senza dichiararsi, sino alla sepoltura ufficiale della Bolognina. Restò sul campo, stranamente, la parola «socialismo», sulla bocca – che so? – di Enrico Boselli o, a volte, di Giuliano Amato, o (mi pare) a strappi anche su quella di Massimo D’Alema. Ma è chiaramente un residuato bellico, un fronzolo. Sicuramente allude ad altro. Ammesso che alluda. In fondo si rompeva, o si scioglieva, quell’ambiguità che aveva sospinto Togliatti a parlare del Partito comunista italiano come di una «giraffa». Il comunismo italiano, nonostante le nefandezze e le colpe che gli hanno imputato via via i suoi avversari, si recinge e riassume nel compito di sostenere l’evoluzione democratica di un capitalismo segnato da passioni e rigurgiti autoritari, da violenze antiche e moderne e da lunghe angustie e salti improvvisi. Giunto, in sostanza, a questa scelta e autolimitazione, alla metà degli anni Sessanta, è chiaro che il PCI subirà il Sessantotto, anche se fornirà ad esso – è stupido dimenticarlo – quadri, truppe, passioni. E fecondità di ricerche, capacità di scoperte. E quando l’onda sessantottina e l’«autunno caldo» si frangeranno e rifluiranno, il PCI apparirà ancora come speranza di cambiamento prima di tutto a un’onda di giovanissimi che avanzavano sulla scena, quasi scavalcando i sessantottini, e alle masse femminili che venivano proclamando la loro alterità. Apparirà come la forza politica in campo che può mettere in discussione in Italia l’eterna preminenza della Democrazia cristiana. Moro stesso parlerà della forza comunista (il nome è ancora quello) come una possibile alternanza.